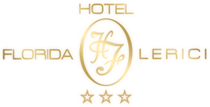Miglior prezzo garantito
Dalle origini fino a oggi
I primi insediamenti sul territorio sono noti fin dai tempi degli etruschi, successivamente la sua particolare posizione
fece di Lerici un porto naturale, prima per i Liguri, poi per i Romani.
Durante il basso Medioevo cominciò ad assumere un ruolo più importante: fu in questo periodo storico
che il famoso Castello San Giorgio, simbolo storico-architettonico del borgo,
diventò oggetto di contesa tra le repubbliche marinare di Genova e Pisa.
Durante il periodo del romanticismo, Lerici fu visitata da grandi artisti che la scelsero come meta del loro Grand Tour,
come i poeti inglesi Shelley e Byron, ispirati dalla sua atmosfera piena di fascino.
Oggi, la Perla del Golfo dei Poeti è scelta dai turisti per le sue spiagge e le sue acque cristalline, ma anche per l’atmosfera tipicamente ligure che si respira percorrendo i colorati caruggi del borgo.